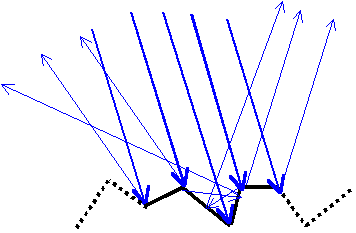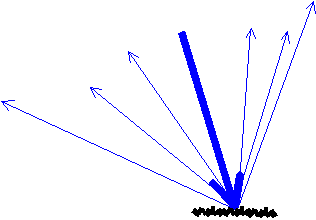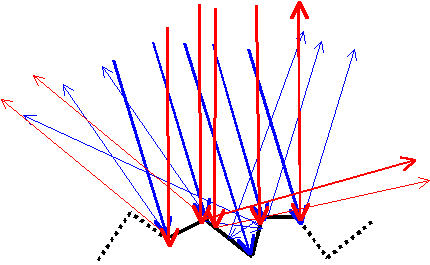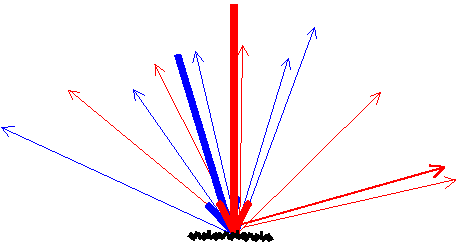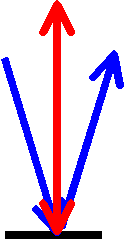|
Obiettivo
Studiare il comportamento della luce quando incontra una superficie piana ruvida.
|
|||||||||
|
Materiale
|
|||||||||
|
Come procedere 1. Disporre su un tavolo un foglio bianco e, perpendicolare ad esso, un foglio di cartoncino colorato; dirigere la torcia o il proiettore (in cui sia stato eventualmente inserito un telaietto con carta nera forata), verso il cartoncino colorato. Osservare attentamente la superficie bianca e quella colorata sia in ambiente illuminato sia in ambiente oscurato. Ripetere l’esperienza con cartoncini e stoffe di diversi colori. 2. Disporre su un tavolo un foglio bianco e, perpendicolare ad esso, la lastra smerigliata. Dirigere il fascio laser verso la lastra. In un ambiente oscurato osservare attentamente la superficie bianca al di qua e al di là della lastra.
|
|||||||||
Cosa
si nota
|
|||||||||
|
Conclusioni e interpretazione La lastra e il cartoncino, intercettano il fascio di luce incidente con la loro parte superficiale rivolta verso la sorgente. La piccola macchia rossa che si vede sulla lastra o la macchia fortemente illuminata che si vede sul cartoncino indicano che la luce del fascio colpisce la superficie e viene rinviata nello spazio circostante. Possiamo concludere allora che la luce che colpisce il foglio bianco proviene dalla lastra e dal cartoncino rispettivamente. Il foglio bianco intercetta parte della luce diffusa e diventa anch’esso sorgente secondaria di luce ulteriormente diffusa. Questa viaggia nello spazio e giunge ai nostri occhi permettendoci di vedere sul foglio bianco una zona illuminata, in modo fortemente attenuato, del colore del laser o del cartoncino colorato.
E’ possibile utilizzare il modello a raggi e le leggi della riflessione per interpretare gli aspetti geometrici della diffusione, schematizzando la superficie ruvida dei corpi diffondenti come un insieme di porzioni piane molto piccole, diversamente orientate nello spazio una rispetto all’altra, ciascuna delle quali si comporta come una superficie riflettente. Mettere disegno Zanetti senza raggi (con lente di
ingrandimento) Ogni raggio che colpisce la superficie viene riflesso, secondo le regole che
abbiamo visto, in una direzione che dipende sia dalla direzione di incidenza del
raggio, sia dall’orientazione della piccolissima porzione di superficie piana
(microsuperficie) su cui incide. Di conseguenza l’insieme dei raggi riflessi
non può più essere considerato come un unico “fascio”, bensì come un
insieme di fascetti provenienti ciascuno da ogni porzione piana di superficie,
che si propagano nello spazio in direzioni diverse.
La distribuzione nello spazio della luce diffusa da un oggetto a superficie rugosa è determinata dalla sovrapposizione dei fascetti provenienti dalle singole microsuperfici. Viene distrutto l'ordine complessivo della distribuzione dei raggi di luce che esisteva nel fascio incidente. Questo vale anche per il fascetto del laser, che ha una sezione di qualche millimetro di diametro, molto più grande delle minime dimensioni delle sporgenze che rendono una superficie otticamente ruvida (queste dimensioni minime sono molto inferiori allo spessore di un foglio di carta[1]). Nel caso di oggetti trasparenti a superficie ruvida, come la lastra smerigliata, vale un discorso analogo per la luce trasmessa, che risulta ugualmente “disordinata”. Si può utilizzare lo schema precedente, tracciando i fascetti rifratti da ogni piccola superficie piana oltre a quelli riflessi. La lastra smerigliata “incolore” modifica la direzione di propagazione della luce incidente che viene rimandata (e in parte trasmessa) in un fascio aperto e disordinato. Gli aspetti non geometrici della diffusione sono legati a fenomeni di assorbimento della luce e non sono interpretabili con il modello a raggi. La luce diffusa risulta meno intensa di quella incidente in quanto parte di essa è stata assorbita e/o rifratta e gli oggetti che ordinariamente ci appaiono colorati diffondono solo alcune delle componenti cromatiche della luce che li colpisce. |
|||||||||
|
[1] Lo spessore di un foglio di carta è circa 0,1 mm. Una superficie può essere considerata otticamente piana se ha sporgenze di dimensioni lineari inferiori a circa un millesimo di millimetro. Per ottenere questo valore bisognerebbe considerare l’aspetto ondulatorio e gli effetti di diffrazione che si manifestano per ostacoli o fori di dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda.
|
|||||||||