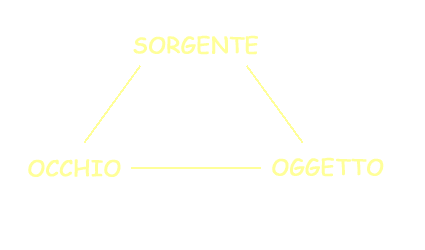|
Dai verbali di Loretta Ferrante Roma 18-23-25 febbraio e 2 marzo 1999 Lavoro in laboratorio:
Tempo: 1h+1h+1h+1h Le due classi sono state divise in quattro gruppi che a turno hanno partecipato all'attività di laboratorio. Ciò che all'esterno era impossibile fare, cioè separare le variabili, è stato invece realizzato in laboratorio. Le prime esperienze hanno riguardato le sorgenti. Sono state analizzate tre diversi tipi di sorgenti: lampadina mignon, lampada, puntatore laser. Si è cercato di classificare con diversi criteri le sorgenti di luce: naturali-artificiali, primarie-secondarie, estese-puntiformi, intense - meno intense, bianche-colorate. Attraverso le esperienze, i ragazzi sono stati portati a focalizzare la loro attenzione sulle ombre che si proiettavano sia sul piano di appoggio che sullo schermo: ombre divergenti o parallele, presenza o meno di penombra. Per osservare bene la penombra sullo schermo verticale abbiamo dovuto coprire il piano orizzontale con un cartoncino nero. Il riflesso del piano bianco e lucido era molto fastidioso. L'esperienza con il puntatore laser è stata sicuramente quella più ricca di spunti. Roma 4/03/99
Tempo: 1h Si fa il punto della situazione in classe ripercorrendo le tappe della nostra attività finora svolta. I ragazzi sembrano aver interiorizzato a fatto propria la considerazione che abbiamo incontrato due diverse situazioni: una incontrollabile (esperienza esterna) dove la variabili non possono essere separate e l'altra controllabile (laboratorio) con la possibilità di isolare le variabili per studiarle singolarmente. Non perdono occasione per ripetere che il Sole è una sorgente incontrollabile. Emerge dalla discussione collettiva che l'esperienza più sorprendente e anche più convincente è stata quella realizzata con il puntatore laser. Vorrei spiegare perché diciamo più convincente. Finora per loro la luce era qualcosa che comunque si vedeva, con le lampadine sia mignon che quella più grande, tutto sommato veniva confermata la loro convinzione . Riuscivano a vedere in qualche modo un cono di luce fuoriuscire dalle sorgenti. Con il laser invece hanno potuto verificare ciò che cercavano, forse finora inutilmente, di far loro comprendere, ossia che noi "vediamo" la luce solo perché ci sono oggetti che la riflettono. Veder comparire magicamente il raggio di luce emesso dal laser grazie al fumo di una sigaretta, è stato sicuramente più utile di tante parole o esempi. La riflessione ci ha portato ad una classificazione delle sorgenti attraverso lo studio delle ombre ed abbiamo concordato il seguente schema:
Ho posto la domanda:" Ma il Sole che tipo di sorgente sarà? Sono state fatte delle ipotesi che saranno poi verificate all'esterno(quando finalmente smetterà di piovere!). Il Sole dovrebbe essere una sorgente estesa, lontana e colorata (gialla). Vedremo. Riparleremo anche degli spazi di ombra scoperti in laboratorio. Tutti erano fermamente convinti che l'ombra fosse piana, scoprire che c'è uno spazio in cui ci si può "nascondere dalla luce" è stata una nuova conquista. Roma 6/05/99 Lavoro
in laboratorio: Oggi ho proposto ai ragazzi delle esperienze sulla scomposizione e ricomposizione della luce. Mi sono servita del prisma per far osservare la diversa composizione della luce proveniente da diversi tipi di sorgenti. Abbiamo scomposto sia la luce del Sole che quella di un proiettore per diapositive (utilizzando anche filtri colorati: verde, rosso e blu). Ho chiesto ai ragazzi di osservare attentamente gli spettri luminosi che si formavano nelle diverse situazioni e di confrontarli tra loro. Le osservazioni si sono limitate alla valutazione del diverso spessore che presentavano le varie bande colorate. I ragazzi hanno osservato che nel caso delle sorgenti colorate, la banda più estesa era proprio quella del colore della sorgente: con il filtro blu, la banda più estesa era quella blu e così per gli altri colori.
E' sempre vero? Ho trovato difficoltà nel gestire il prisma, soprattutto nel posizionarlo nel modo più corretto. Una piccola rotazione del prisma corrispondeva ad una variazione dello spettro (nello spessore e nitidezza delle bande). Mi chiedo se ci sono delle regole precise da rispettare, io non lo so. In questa esperienza mi sono limitata ad un'analisi qualitativa del fenomeno, non mi sono addentrata in spiegazioni che coinvolgevano la diversa lunghezza d'onda dei diversi colori. Ho utilizzato, poi il disco di Newton per la ricomposizione della luce bianca per ritrovare la sintesi additiva già osservata nell'esperienza delle ombre colorate. Dai verbali di Anna Simonelli
Il giorno 6 febbraio abbiamo lavorato in classe. Siamo partiti dalle domande "come vediamo?","Cos'è che ci permette di vedere?". Ci siamo trovati tutti d'accordo nello stabilire che vediamo perchè c'è la luce emessa dalle sorgenti, perchè ci sono gli occhi e perchè c'è qualcosa da vedere. Quindi per poter vedere servono:
Ma stabilire questo non è bastato perchè siamo stati sollecitati a riflettere su come questi tre elementi sono legati tra loro. Ognuno di noi ha detto la propria e siamo alla fine arrivati a questo schema.
Occhio e sorgente sono legati tra loro in quanto "se abbiamo l'occhio ma non la luce, non vediamo" ma "non vediamo anche se c'è la luce ma non l'occhio". La classe poi è stata divisa in due gruppi, siamo scesi in laboratorio un gruppo di alunni della 2^ H e della 2^ F per studiare le sorgenti. Abbiamo iniziato con una sorgente primaria, faretto alogeno di 20 watt. Abbiamo posto la sorgente luminosa ad una certa distanza dallo schermo e tra sorgente e schermo abbiamo messo l'oggetto di cui dovevamo osservare l'ombra. Abbiamo osservato che l'ombra proiettata sullo schermo appariva con penombra e di colore grigio chiaro. Abbiamo poi spostato l'oggetto e osservato che se lo avvicinavamo alla sorgente la penombra aumentava, mentre se lo allontanavamo dalla sorgente la penombra diminuiva fino a scomparire e darci un'immagine nitida. Abbiamo osservato che si passava da una zona di ombra e penombra ad una intermedia (con penombra sfumata) ad una in cui la penombra scompariva e c'era solo l'ombra. La professoressa ci ha suggerito di misurare la distanza tra sorgente ed oggetto e quella tra oggetto e schermo quando non c'era più penombra. Abbiamo calcolato il loro rapporto ed era 1/7; abbiamo dimezzato poi la distanza tra sorgente e oggetto e ricercato il punto in cui non c'era penombra, abbiamo ripetuto le misurazioni e osservato che anche questa volta il rapporto era 1/7. Abbiamo quindi concluso che la penombra non è determinata solo dalla diostanza sorgente-oggetto e oggetto-schermo, ma dal loro rapporto. Abbiamo poi fatto una prima classificazione delle sorgenti:ESTESA se c'è penombra e ombra, PUNTIFORME se c'è solo ombra. La professoressa ci ha poi chiesto se l'ombra che vedevamo era "piatta". Le risposte sono state diverse, la maggior parte di noi ha detto che era piatta. Abbiamo però osservato che se mettevamo un secondo oggetto dietro al primo, la sia ombra non si vedeva e questo perchè cadeva nello spazio d'ombra del primo. Sul piano del tavolo abbiamo osservato che se la sorgente era vicina all'oggetto i raggi divergevano, mentre se allontanavamo l'oggetto dalla sorgente tendevano ad essere paralleli, abbiamo allora fatto un'altra classificazione delle sorgenti: LONTANA se i raggi sono paralleli, VICINA se i raggi sono divergenti. La seconda volta che siamo scesi in laboratorio abbiamo lavorato con una sorgente più piccola della precedente e ripetuto le osservazioni. Abbiamo poi usato il laser. La cosa che più ci ha colpito è stata osservare la luce che si propaga il linea retta, infatti usando il fumo di una sigaretta abbiamo potuto visualizzare il raggio di luce perchè la luce si riflette sulle particelle di fumo che si comportano come sorgenti secondarie. Verbale del 4 marzo In classe abbiamo fatto il punto di quanto osservato in laboratorio. Quello che ha colpito tutti è stato vedere il raggio del laser perchè, per noi, è stata la prova che vediamo la luce perchè questa si riflette sulle particelle di fumo, quindi noi non vediamola luce ma gli effetti della luce sugli oggetti. Dall'esame delle sorgenti, che abbiamo potuto controllare, abbiamo dato le seguenti definizioni: naturale, artificiale, primaria, secondaria, puntiforme ed estesa, lontana e vicina. La sorgente naturale è quella che esiste in natura (Sole). La sorgente artificiale è quella costruita dall'uomo (lampada). La sorgente primaria è quella diretta (Sole). La sorgente secondaria è la luce riflessa. La sorgente puntiforme crea un'ombra ma senza penombra. La sorgente estesa crea un'ombra con penombra (a seconda della distanza). A questo punto ci siamo chiesti: il Sole che tipo di sorgente? come arrivano i suoi raggi? Secondo noi i raggi del Sole arrivano paralleli, la professoressa ci ha detto che la prossima volta ritorneremo all'aperto e osserveremo come si comporta il Sole.
Dal verbale di Ivaldo Grassi da Terni
Ho introdotto l'argomento proponendo agli alunni le seguenti domande:
Dalla discussione è emerso che tutti erano consapevoli che per vedere sono necessarie due cose: occhio e luce; sulla seconda domanda ho avuto risposte meno sicure e variegate che tendevano ad identificare la luce con la sorgente o con la causa (l'energia elettrica); sulle sorgenti luminose hanno mostrato più sicurezza elencando molte sorgenti luminose e qualcuno ha distinto quella primaria da quella secondaria (sole e luna ad esempio): su come si propaga la luce la risposta più immediata è stata in tutte le direzioni ma non era evidente la consapevolezza del percorso della luce. Siamo quindi giunti alla conclusione che la luce è "un qualcosa" che viene emesso da una sorgente luminosa è colpendo il nostro occhio ci permette di vedere gli oggetti"; per quanto riguarda il percorso della luce abbiamo deciso di osservare alcune sorgenti luminose per chiarirci meglio le idee.
Ho portato in classe alcune sorgenti luminose (candela, lampadina grande, lampadina piccola, torcia elettrica, proiettore per diapositiva, luce laser) e dopo aver oscurato l'aula ho fatto osservare le diverse sorgenti luminose. Quando ho utilizzato la torcia ed il proiettore i ragazzi hanno osservato che si formava un cono di luce che si allargava, ma che comunque dava l'impressione di andare in linea retta. Ha questo punto ho schermato la torcia con alcuni cartoncini neri su cui avevo pratico dei fori via via più piccoli che, restringendo il fascio di luce, dava sempre più la sensazione di una propagazione in linea retta; il raggio laser ha confermato l'osservazione, la luce si propaga lungo linee rette ed il cono di luce che viene ristretto lo abbiamo chiamato raggio di luce. A conferma di questa conclusione, accartocciando un foglio di cartoncino nero e tolto l'oscuramento, ho chiesto ad un alunno di osservare i compagni con un solo occhio attraverso il cilindro e di fermarsi quando vedeva il viso un particolare compagno; abbiamo così verificato che per vedere il compagno ci si deve fermare esattamente allineando l'occhio con il viso. Abbiamo anche classificato le diverse sorgenti in estese e puntiformi facendo qualche semplice osservazione sulle ombre e sulle penombre. Dal verbale di Nunzio Canceri
[…] Allora si sono abbassate le serrande, si è fatta sedere una ragazza con un libro aperto al centro della classe e dietro di essa si è messa un'altra ragazza con un foglio bianco sopra la testa della prima; una terza ragazza con una torcia elettrica illuminava il foglio bianco. La ragazza seduta riusciva a leggere; ripetendo l'esperimento con un foglio nero, la ragazza aveva difficoltà a leggere. Alzate le serrande, la solita Debora ha osservato: "la luce che arriva ai nostri occhi è la luce proveniente dal muro", come i pianeti che "si servono di un'altra luce per fare luce". Dal verbale di Maribella D'Antona Milano, 2-3-99 […] Ho chiesto loro di fare un elenco (almeno 20 oggetti) di cose che "fanno" luce. Questo per introdurre sorgente primaria e secondaria. Quelli che ritenevano la luna sorgente di luce, naturalmente l'hanno messa in elenco e sono stati aggrediti dagli altri. E' stata poi creata una lista comune di classe di oggetti che fanno luce (luna esclusa), per compito i ragazzi devono classificarli. Per capire se un oggetto fa luce o la riflette una allieva, Roberta, propone una esperienza che avrei fatto fare, mi viene quindi utilissima la sua proposta, perché ciò che viene da loro è sempre molto più efficace: la scatola nera. (una scatola di scarpe nella quale metto gli oggetti e guardo dentro un buchino, se un oggetto è sorgente primaria lo vedo se no non vedo niente). Vorrei proporre anche di
illuminare un cartoncino rosso, blu etc. con una torcia e osservare che
anche gli oggetti intorno appaiono colorati di rosso etc. per meglio far
capire la sorgente secondaria. Introduco così anche lo schema occhio
sorgente oggetto, anche se non penso di parlarne esplicitamente adesso,
vediamo se quando si fanno queste esperienze i miei allievi sono
abbastanza vicini a capirlo a no. Dai verbali di Paola Catalani
[…] Nella discussione è emerso subito il problema delle sorgenti primarie e secondarie, che i ragazzi hanno identificato come gli oggettyi che riflettono o meno la luce. Se per la Luna non c'è stata molta difficoltà, è nata una discussione accesa con specchi e vetri, a cui poi si sono aggiunti plastiche e metalli e pietre preziose, che alla fine sono stati accettati nell'elenco delle sorgenti, ma con qualche dubbio. Ho fatto classificare gli elementi dell'elenco:
A questo punto abbiamo chiamato primarie e secondarie le sorgenti dell'ultimo gruppo e ci siamo lasciati con la domanda: una sorgente può essere sia primaria sia secondaria?
Ancora una volta il sole ci ha tirato un brutto scherzo. Dopo una settimana di bel tempo, l'unico giorno a cielo coperto è stato quello della lezione di scienze. I ragazzi erano arrabbiatissimi!
Siamo rimasti in classe a controllare le loro classificazioni delle sorgenti di luce in primarie e secondarie. Il lavoro era stato fatto in gruppo e discusso la lezione precedente, ma sono emersi nuovi dubbi ed errori dopo la riflessione individuale. Dubbi: gli oggetti fosforescenti, che " prendono luce dal buio", sono sorgenti primarie o secondarie? Come funzionano gli occhi di gatti? Si possono considerare anch'essi sorgenti? Errori: fondamentalmente è uno solo, molti ragazzi confondono le sorgenti primarie con la fonte energetiche che le alimenta. Ad esempio considerano le scintille secondarie perchè sono generate dalla fiamma, nello stesso modo la lampadina, accesa grazie all'energia elettrica. Non mi aspettavo questa confusione. Un commento interessante di Marina: "ma così nelle sorgenti secondarie non rimane più nulla!"
E' incredibile, ma anche oggi il sole è mancato, o meglio ha fatto capolino solo dopo le 12, perciò non aveva molto senso fare osservazioni outdoor. Avevo già preparato un'alternativa indoor sull'osservazione di sorgenti e ombre. Ho portato i ragazzi in due gruppi nell'aula oscurata e abbiamo osservato l'ombra prodotta da diversi tipi di sorgenti luminose. Come a Lugo, avevo a disposizione varie lampadine:
I ragazzi avevano a disposizione stuzzicadenti su basi di pongo, blocchetti di legno, altri oggetti. Entrambe i gruppi hanno notato che le due lampade al neon, affiancate sul soffitto (a distanza di circa 10 cm), producevano ombre doppie nei loro oggetti. Accendendo a turno le varie lampade e modificando l'intensità di ciascuna siamo arrivati a concordare che:
Siamo rimasti tutti soddisfatti dell'esperienza; l'atteggiamento dei ragazzi in laboratorio è stato molto positivo, procedono a piccoli passi ed incominciano a strutturare con qualche autonomia il loro percorso di conoscenza. Questa volta tutti scriveranno il verbale del lavoro che poi valuterò. |