|
|
|
|
| "Le
cose devono essere apprese solo per essere nuovamente disimparate, oppure, cosa più
probabile, per essere corrette" R. Feynman "Non si capisce una cosa se non la si capisce in
più di un modo" |
Sommario
| Prima di tutto un commento generale | |
| In prima approssimazione | |
| Tutto questo in teoria, ma in pratica? | |
| Cosa fare con i ragazzi ? | |
| Potremmo essere più precisi? | |
| Non trascuriamo anche le risorse in rete |
![]()
Prima di tutto un commento generale, sul quale però mi piacerebbe discutere.
Come per ogni concetto della fisica (della matematica e così via) che ci siamo già trovati o che ci troveremo ad affrontare, bisogna pensare che le cose si possono affrontare e capire a più livelli, in generale di complessità ed astrazione crescente. Questo vale per noi, quando cerchiamo di capire, e a maggior ragione deve valere per i ragazzi.
In particolare in fisica si parla di approssimazioni, spesso legate agli strumenti di misura che si hanno a disposizione. Così nell’approssimazione, dovuta all’uso di uno strumento, due cose possono coincidere (lo abbiamo già visto a proposito del parallelismo dei raggi solari: nell’approssimazione dei nostri strumenti di misura i raggi sono paralleli, hanno cioè la stessa direzione), mentre con un altro strumento si possono vedere come due cose distinte (ad esempio quella che ad occhio nudo sembra una sola stella si rivela invece una coppia di stelle, e così via).
Le note che seguono sono suggerimenti a diversi livelli di approssimazione, sono per gli insegnanti per cercare di capire loro meglio, non devono essere prese come definizioni da passare subito ai ragazzi.
![]()
In prima approssimazione.
Possiamo parlare di Nord - Sud - Est - Ovest come di quattro zone, delle quattro zone
a cui già accennavo negli appunti sull’orizzonte.
In seconda approssimazione, guardando da Terra verso il cielo.
Ogni osservatore poggia i suoi piedi sul piano orizzontale delimitato per lui
dall’orizzonte e sta in posizione eretta, verticale (perpendicolare al piano
orizzontale). Sopra di sé ha il cielo, quella che viene chiamata la sfera
celeste e che spesso si rappresenta con una "cupola".
Quando il Sole si sposta durante il giorno fa un percorso in cielo, sulla sfera celeste, a forma di arco. A Milano (alla nostra latitudine) questo arco non incontra mai la verticale.
Il punto più alto di questo percorso sull’orizzonte locale prende il nome di Sud. Così definito, il Sud è un punto nel cielo.
Anche il Nord è un punto nel cielo, nella nostra approssimazione possiamo dire che è il "punto" in cui di notte si vede la stella Polare.
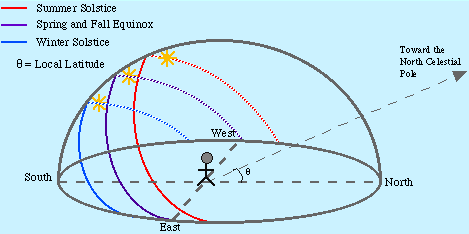
L’Est è il punto in cui sorge il Sole sull’orizzonte locale agli equinozi e l’Ovest il punto in cui il Sole tramonta sull’orizzonte locale agli equinozi. L’Est e l’Ovest sono dunque due punti sul piano orizzontale, sulla linea dell’orizzonte.
Per avere 4 punti tutti sull’orizzonte (e raccordarsi alle zone della approssimazione precedente) si devono "proiettare" il Nord e il Sud sul piano orizzontale locale. La direzione Nord - Sud è dunque la direzione delle ombre a mezzogiorno, inteso come istante in cui il Sole si trova nel punto più alto.
In terza approssimazione, guardando la Terra nel suo complesso (usiamo il mappamondo).
I due punti Nord e Sud ottenuti col metodo delle ombre appartengono al meridiano che passa per il punto in cui si trova l’osservatore e quindi indicano la direzione del Polo Nord e del Polo Sud (i punti di intersezione dell’asse terrestre con la superficie della Terra) rispettivamente.
La direzione Est - Ovest è la direzione perpendicolare a quella Nord - Sud e quindi è la direzione del parallelo locale.
![]()
Tutto questo in teoria, ma in pratica?
Quale direzione trovare sperimentalmente e come? Con la bussola? E perché?
La Terra si può immaginare come una grande calamita con due poli magnetici Nord e Sud che per coincidenza al momento attuale si trovano molto vicini ai poli Nord e Sud di cui abbiamo parlato prima. Quindi se si trova il Polo Nord magnetico si trova anche quello "geografico - astronomico". La bussola serve proprio a indicare i poli magnetici, perché il suo ago (una piccola calamita anch’esso) tende a orientarsi proprio con le punte dirette rispettivamente verso Nord e Sud (magnetico).
Una volta determinata sperimentalmente la direzione Nord - Sud con la bussola si potrebbe verificare che questa coincide, in prima approssimazione (entro la sensibilità e la precisione dei nostri strumenti di misura), con la direzione che si ottiene con metodi astronomici.
Conviene poi determinare la direzione Est - Ovest, come perpendicolare alla linea Nord - Sud. La determinazione diretta è complicata perché il punto esatto del sorgere e tramontare del Sole agli equinozi è per molti motivi (orizzonte non piatto, effetto della rifrazione della luce del Sole da parte dell’atmosfera...) quasi impossibile.
![]()
Conviene partire con le zone nel cielo e precisare via via i concetti anche in collaborazione con l’insegnante di geografia. Conviene partire portandoli fuori ad osservare davvero prima di leggere le cose sui libri e accettare le definizioni degli altri. Possiamo insistere sul fatto che alle nostre latitudini il Sole non è mai a perpendicolo sulle nostre teste, in nessuna ora di nessun giorno dell’anno, ma sarebbe molto importante che i ragazzi se ne rendessero conto osservandolo direttamente.
Forse più difficile è rendersi conto che il Sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente ad Ovest solo nei giorni degli equinozi, ma anche in questo caso, osservando attentamente e trovando il modo di registrare le osservazioni, si vede bene che il Sole non sorge nello stesso punto tutti i giorni e che tra i due estremi (punto del sorgere nei giorni dei solstizi) c’è una differenza notevole (sono circa 30° a destra e a sinistra dell’Est). Analogamente per l’Ovest e il tramontare.
![]()
Certamente: la Polare non si trova esattamente nello punto del Nord celeste; il Polo Nord magnetico non coincide esattamente con quello geografico - astronomico.
Andrebbero definiti meglio meridiani, paralleli, latitudine, longitudine...
Non tutto ora, non tutto al grado di approssimazione massimo, non tutto... nei miei appunti!
![]()
Non trascuriamo anche le risorse in rete
In rete, sul WWW, c’è un bellissimo sito che presenta le foto della Terra vista dal Sole o da un satellite posto a diverse latitudini, in diversi giorni e ore dell’anno.
Sostituiscono l’esperienza diretta che in questo caso non è possibile.
Occorre un po’ di tempo sia per caricare le immagini che per capire cosa si sta vedendo e quali sono i parametri che conviene cambiare (provate voi prima di lavorarci con i ragazzi).
Ve ne porto qualche esemplare alla riunione.
C'è poi un altro sito interessante dove si possono trovare rappresentazioni del percorso del Sole sulla sfera celeste a diverse latitudini, come quella riportata più sopra.
La sfera celeste è una superficie sferica immaginaria, a grande distanza
dalla Terra, con la Terra al suo centro.
Si parla di equatore celeste (dove il piano che passa per l’equatore della
Terra incontra la sfera celeste); di Polo Nord e di Polo Sud celeste
(punti di intersezione dell’asse terrestre con la sfera celeste); di cerchio
massimo (ad esempio per i due poli); di Zenit (dove la verticale per
l’osservatore incontra la sfera celeste); di meridiano celeste (cerchio per
il poli e lo Zenit).