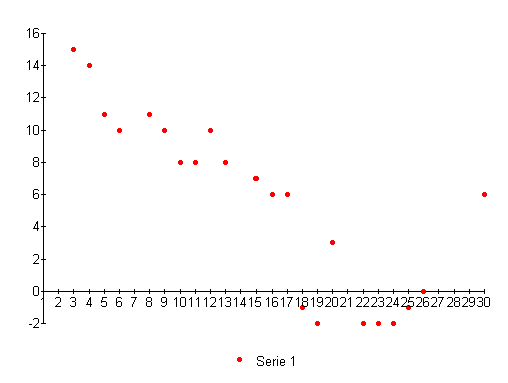7
gennaio 2000
Decido di occuparmi con
i ragazzi della temperatura finale di un miscuglio di liquidi dello stesso
tipo ma a diversa temperatura.
Pongo il problema: se ho
due quantità di acqua uguali, ma a temperatura diversa, posso prevedere
quale sarà la temperatura del loro miscuglio?
Capisco che è meglio
proporre un esempio: se mescolo 100 ml di acqua a 20° con 100 ml di
acqua a 60°, quale sarà la temperatura del miscuglio?
All’inizio vengono espresse
diverse soluzioni (temperatura finale come somma delle due temperature,
temperatura finale come differenza delle due temperature, e così
via), ma piano piano si consolida l’idea della media, proposta da due ragazzi
che la conoscono dalle elementari.
Non ci resta che provare.
Andiamo in laboratorio per
mescolare due quantità uguali di acqua a temperatura diversa, fare
la previsione della temperatura finale e controllarla sperimentalmente.
I ragazzi pasticciano, anche
perché c’è poco tempo: ci ripromettiamo di ripetere l’esperimento.
14
gennaio 2000
In laboratorio ripetiamo
l’esperimento del 7 gennaio perché due gruppi su cinque l’hanno
eseguito in modo scorretto.
I ragazzi devono misurare
due quantità uguali di acqua (scelgono 100 ml, perché si
sentono sicuri nell’usare il becher graduato),
18
gennaio 2000
Si disegna il grafico della
temperatura di dicembre e si calcola la temperatura media (T media = 2,5°).
Parliamo ancora degli stati
di aggregazione della materia.
26
gennaio 2000
Mi propongo di arrivare
con i ragazzi alla comprensione e alla capacità di utilizzare la
media
ponderata.
Allo scopo li esercito con
problemi graduati, dei quali il primo è il seguente.
Problema 1
"Ho tre becher che contengono
ciascuno la stessa quantità di acqua. L’acqua nel primo becher è
a 12°; la temperatura dell’acqua nel secondo e nel terzo becher è
la stessa, cioè 57°. Se mescolo l’acqua dei tre becher, qual
è la temperatura del miscuglio?"
I ragazzi discutono e, dopo
aver proposto di sommare le temperature e dividere per 2, nel ricordo della
precedente attività, riflettono, cambiano idea e si correggono:
sommeranno le tre temperature e divideranno per 3, perché le quantità
uguali sono 3. E’ di aiuto la proposta di disegnare i tre contenitori di
liquido con il liquido allo stesso livello.
Ecco l’espressione risolutiva
finale:
Temperatura finale del miscuglio
= (12 + 57 + 57) : 3 = 42°
Problema 2
"Ho due becher;
il primo contiene 100 ml di acqua a 10°, il secondo 200 ml di acqua
a 88°.
Se mescolo i due contenuti,
quale sarà la temperatura del miscuglio?"
Per un bel po’ di tempo
i ragazzi non si rendono conto che il problema è uguale al precedente;
non capiscono che un becher con quantità doppia equivale ai due
becher con quantità uguali e stessa temperatura del Problema 1.
Dopo aver disegnato la nuova situazione alla lavagna, si accende finalmente
la lampadina e risolvono il problema in modo formalmente identico al precedente.
Temperatura finale del miscuglio
= (10+ 88 + 88) : 3 = 186 : 3 = 42°
Domando se l’espressione
risolutiva si può scrivere in modo diverso; qualcuno suggerisce
la forma seguente:
Temperatura finale del miscuglio
= (10+ 2 .88) : 3 = 186 : 3 = 42°
28
gennaio 2000
Continuo a proporre problemi
fra la costernazione generale, promettendo di far loro mettere in pratica
quanto prima ciò che stanno imparando.
Problema 3
"Ho un bicchiere di acqua
a 15°; verso tre bicchieri di acqua in un pentolino e scaldo fino alla
temperatura di 75°. Mescolo l’acqua del pentolino con quella del bicchiere.
Qual è la temperatura
del miscuglio?"
I ragazzi disegnano i quattro
bicchieri pieni d’acqua e riesce loro facile scrivere l’espressione risolutiva:
Temperatura finale = (15
+ 75 + 75 + 75) : 4 = 240 : 4 = 60°
Pochi abbreviano:
Temperatura finale = (15
+ 3 . 75) : 4 = 240 : 4 = 60°
Problema 4
"Ho due taniche uguali
di acqua a 21°. Le mescolo con tre taniche di acqua a 78°.
Qual è la temperatura
finale del miscuglio?"
I ragazzi disegnano le taniche
e scrivono velocemente la formula più sgranata, che riesce loro
più facile:
Temperatura finale = (21
+ 21 + 78 + 78 + 78) : 5 = 55° circa
febbraio
2000
Ancora problemi su miscugli
di acqua a temperature diverse, ma con la promessa che la volta prossima
si sperimenta.
Problema 1
"Ho 3 kg d’acqua a 95°
e li mescolo con 7 kg d’acqua a 18°. Qual è la temperatura del
miscuglio?"
Temperatura finale = (95
. 3 + 18 . 7) : 10 = 411 : 10 = 41,1°
Problema 2
"Sono in laboratorio;
con il cilindro graduato prelevo 180 ml di acqua del rubinetto a 15°.
Prelevo poi altri 220
ml di acqua e la scaldo fino a 88°. Mescolo le due acque. Qual è
la temperatura del miscuglio?"
I ragazzi sono interdetti:
non sanno come affrontare un problema con unità di misura piccole
come il millilitro e con dati dell’ordine di grandezza delle centinaia.
Li aiuto mimando tante piccole
tanichette ciascuna da un millilitro, e la soluzione si fa strada.
Temperatura finale = (15
. 180 + 88 . 220) : (180 + 120) = (2700 + 19 360) : 400 = 22 060 : 400
= 55,15°
Problema 3
"Se mescolo 120 ml di
acqua a 14° con 170 ml di acqua a 72°, qual è la temperatura
del miscuglio?"
La capacità risolutiva
si consolida e arriva la soluzione:
Temperatura finale = (14
. 120 + 72 . 170) : (120 + 170) = (1680 + 12 240) : 290 = 13 920 : 290
= 48°
1
febbraio 2000
Finalmente!
Esperimento su un miscuglio
di quantità diverse di acqua a diverse temperature; previsione e
controllo sperimentale della temperatura finale del miscuglio.
Dal quaderno di Serena.
Esperimento
Materiale occorrente:
un fornello elettrico
un cilindro graduato
acqua del rubinetto
due becher
Procedimento.
Abbiamo riempito il primo
becher con 190 ml di acqua (chiamato v1) e il secondo becher con 170 ml
di acqua (chiamato v2). Abbiamo misurato la temperatura che è per
entrambi, v1 e v2, di 12°.
Mettiamo sul fornello v2,
finché non raggiunge una temperatura intermedia fra 70° e 80°.
Togliamo v2 dal fornello
e lo versiamo in v1 e mescoliamo. Misuriamo la temperatura del miscuglio
che è di 40°.
Potevamo prevedere la temperatura
del miscuglio con l’espressione:
Tf = (190 *132 + 170 *75)
/ (190 +170) = 40°
Proviamo ora a generalizzare;
sostituiscono
nella formula precedente ai numeri i simboli utilizzati nella testata delle
tabelle senza difficoltà.
Tf = (v1 . T1 + v2 . T2)
: (v1 + v29)
Vengono complimentati e
assicurati che hanno lavorato più e meglio dei ragazzi di terza
media: contentezza generale.
4
febbraio 2000
Effetti del calore sui liquidi.
Dal quaderno di Andrea
T. ...
Esperimento di dilatazione
dei liquidi con il calore.
Materiale occorrente:
beuta, tappo di gomma forato con tubicino di vetro, acqua
Relazione:
Siamo andati nel laboratorio
di Scienze per constatare se, con il calore a più di 30° delle
nostre mani, riuscivamo a far salire il livello dell’acqua. Infatti, come
quasi tutti sanno, le molecole dei liquidi, se le riscaldiamo, occupano
più volume.
Alcuni sostenevano che il
calore delle mani era troppo poco: ci voleva un fornello.
Abbiamo riempito la beuta
con acqua, l’abbiamo chiusa con un tappo forato e i quel buco abbiamo fatto
passare un tubino di vetro. L’acqua arrivava tra la fine del tappo e dove
si iniziava a scorgere il tubino di vetro.
Con meraviglia di quasi
tutti, dopo qualche minuto che tenevamo la beuta tra le mani, l’acqua era
salita e l’esperimento era riuscito.
8
febbraio 2000
Media delle temperature
di gennaio.
11
febbraio 2000
Effetti del calore sui gas.
Dal quaderno di Serena
I.
Esperimento sulla dilatazione
dei gas.
Materiale occorrente:
una beuta, un palloncino, un elastico, un pentolino per immergervi la beuta,
un fornello, acqua
Procedimento.
Prendiamo il palloncino,
lo incastriamo sulla bocca della beuta e lo fermiamo con un elastico.
Poi riempiamo il pentolino
di acqua del rubinetto e lo mettiamo sul fornello.
Accendiamo il fornello,
vi poniamo il pentolino con l’acqua e immergiamo la beuta con il palloncino;
dopo un po’ che la beuta è nell’acqua il palloncino si gonfia per
via del calore che l’acqua emana.
Conclusione.
Con questo esperimento abbiamo
capito che, con poca acqua riscaldata, l’aria che era dentro alla beuta
si è dilatata in modo che il palloncino si è gonfiato.
L’esperimento è riuscito
perfettamente!!!