
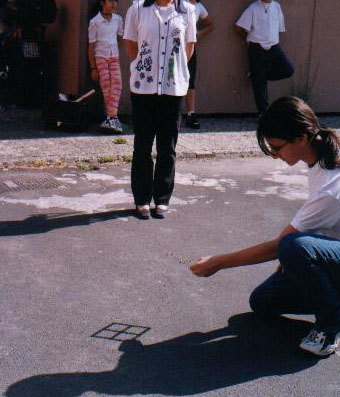
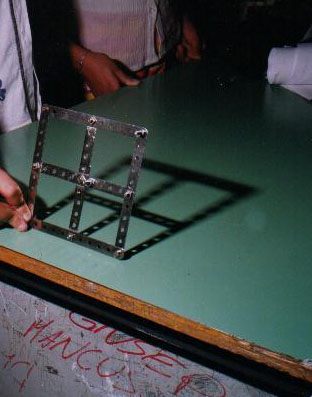

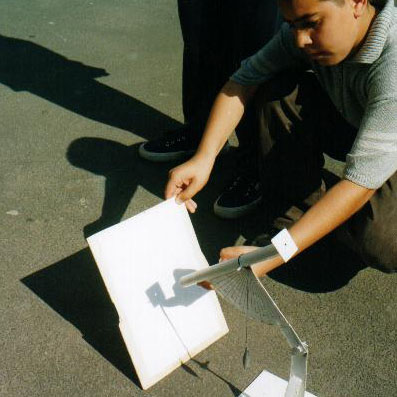


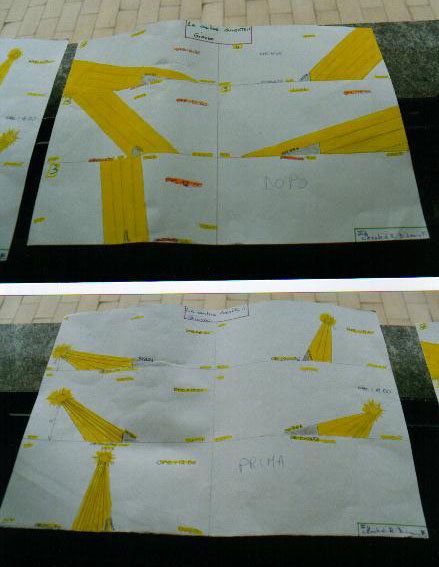


|
|
a) zona di penombra tra la zona illuminata e quella buia; anche con sorgenti più puntiformi c’è la zona di “penombra”; variazione delle ombre dello stecchino sulla patata quando essa ruota intorno alla sorgente o viceversa; la stessa cosa succede con il mappamondo.
b) Vedi a)
c) Stecchino e sorgente artificiale: quando l’ombra dello stecchino oltrepassava il circolo d’illuminazione spariva all’osservazione.
d) mappamondo parallelo modello rappresentativo del sistema Terra-Sole.
e) La direzione dell’ombra nel nostro emisfero può essere solo verso sud e viceversa nell’altro.
f) Mappamondo parallelo: modello rappresentativo del sistema Terra-Sole.
g) Non risponde.
Le
domande iniziali su buio, ombra e nero
creano in alcuni vero sconcerto. Occupano così uno spazio di discussione
iniziale eccessivo, visto che le domande volevano solo porre alcuni dei problemi
a cui si doveva procedere a rispondere anche con i lavori successivi.
Questo
problema è stato poi risollevato in seduta plenaria dove però praticamente
tutto il tempo è stato dedicato ai lavori di chimica e a Temperatura e Calore
della mattina e non c’è stato tempo di riaffrontare e puntualizzare problemi
di luce.
Alcuni
corsisti hanno successivamente mostrato tale sconforto a non ottenere dagli
esperti le risposte alle domande su buio,
ombra e nero che ci hanno costretto preparare degli appunti scritti per il
giorno seguente (v.testo riportato di seguito). Gli stessi appunti hanno invece
suscitato in altri corsisti del gruppo luce forte perplessità vissuti come una
contraddizione al nostro stile di intervento complessivo.
Altri
gruppi o componenti singoli sembrano invece porsi fin troppo pochi problemi e
procedere o per tentativi o seguendo suggestioni più che ragionamenti e
osservazioni sistematiche.
Nel
complesso il lavoro è risultato piuttosto compresso, non ha avuto tempi
adeguati né per la sua realizzazione né per la discussione e revisione
successiva e quindi non ha raggiunto lo scopo di “portare alla
concettualizzazione” che sembravamo esserci inizialmente posti.
documentazione
fotografica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eventualmente
da inserire e rimando al filmato vhs
Scheda esplicativa degli esperti su buio-ombra-nero[1]
Ombra,
buio e nero
si possono considerare tutte come situazioni in cui , per motivi diversi, si
percepisce “assenza di luce”. Cerchiamo
di capire in cosa consistono le differenze tra situazioni che ci hanno portato
nel linguaggio ad avere tre termini diversi per questa assenza di luce.
Richiamiamo innanzitutto una idea
fisica molto generale: quando un oggetto viene colpito dalla luce, in generale
accadono contemporaneamente tre cose:
-
una parte di luce attraversa l’oggetto e passa dall’altra parte
(trasmissione/rifrazione)
-
una parte
viene rimandata verso la sorgente (riflessione/diffusione)
-
una parte
viene intrappolata dentro l’oggetto (assorbimento)
Se
prevale l’assorbimento rispetto alla trasmissione/rifrazione di luce
l’oggetto si considera opaco.
Se si vuole interpretare il colore di
un oggetto bisogna considerare la parte di luce che viene riflessa/diffusa. In
generale colpiti da luce “bianca” (sovrapposizione di diversi colori) gli
oggetti trattengono, assorbono, alcuni colori e ne rimandano (riflettono,
diffondono) altri. La nostra
percezione del colore dipende dalla qualità della luce che colpisce l’occhio
e dalla risposta dell’occhio.
Torniamo
allora al nostro problema
Ombra:
assenza di luce diretta (presenza di luce diffusa)
Per
avere ombra occorre luce proveniente da una sorgente “concentrata” e un
oggetto che rifletta e assorba una alta percentuale della luce che lo colpisce.
Con ombra intendiamo la zona, nello spazio, che si trova “dietro” o
“sotto” l’oggetto (rispetto alla sorgente), cioè la zona in cui non
arriva la luce diretta dalla sorgente. Questa
zona e’ circondata dallo spazio occupato dalla luce diretta . Si crea un
confine più o meno netto tra zona di luce e zona d’ombra, che l’occhio
percepisce se lo spazio d’ombra o di luce vengono intercettati da una
superficie che rimanda luce ai nostri occhi.
Se
ci mettiamo all’ombra, cioè se entriamo nella zona d’ombra, non abbiamo la
sensazione di essere al buio, perché in quella zona arriva comunque luce,
diffusa da tutti gli oggetti, le superfici, che abbiamo intorno e che vengono a
loro volta colpite dalla luce.
La
notte: tra ombra e buio
Vista dall’esterno (vedi mappamondo
parallelo) la notte è “l’ombra della Terra” rispetto al Sole. Stando
sulla Terra si ha una sensazione di buio che però non è mai “completo” per
la presenza di luce diretta proveniente da astri o da sorgenti di luce
“terrestri” e/o per la presenza di luce diffusa, ad esempio dalle nuvole.
Nero: luce
diretta e/o diffusa che colpisce una superficie che a sua volta la diffonde
“poco” .
Si
usa il termine nero quando al nostro occhio arriva luce “priva di colore”
diffusa da una superficie in percentuale molto piccola
rispetto alla luce incidente e alla luce proveniente dall’ambiente
circostante.
Il discorso sul colore ( della luce, degli oggetti) è
difficile da riassumere in poche righe e non può essere fatto studiando solo
le proprietà della luce prescindendo dalla percezione.
Sulla
spiaggia, con un orizzonte molto aperto in tutte le direzioni, in modo
improvvisato e “casuale” N. Lanciano aiuta a riconoscere alcune
costellazioni, alcune stelle e soprattutto i pianeti Giove e Saturno ben
visibili ad oriente e Marte visibile ad occidente, di sera. La presenza della
Luna crescente, che si sposta in modo assai evidente da una sera all’altra,
tra le stelle, ci aiuta a cogliere le differenze tra i corpi fissi e i corpi
erranti del cielo notturno.
Impariamo
ad usare le spanne, col braccio ben teso, per prendere misure di “distanza
angolare” tra gli astri e a valutare “l’altezza” di un astro sopra
l’orizzonte.
Il
racconto di miti aiuta a ricordare e riconoscere gli oggetti del cielo e a dare
un senso alla disposizione nello spazio delle costellazioni. E’ inoltre un
modo, quello di raccontare i miti mentre si osserva il cielo stellato, per
aiutare chi guarda a guardare a lungo, per tutto il tempo della storia, a fare
amicizia e familiarizzarsi con immagini fatte solo di puntini luminosi. E’ un
modo per radicare un guardare a nomi e a immagini evocate che aiuta a ricordare
e a riconoscere. E’ un modo che restituisce ad uno sguardo finalizzato a
capire come si muove il cielo, l’emozione e la complessità del territorio
culturale in cui quell’organizzazione spaziale e temporale hanno preso radici.
|
|
[1] Suggeriamo di guardare al proposito il volume che è stato pubblicato successivamente all’incontro di Belluria da R. Casati, La scoperta dell’ombra, Mondatori 2000