|
|
|||
|
Supporto didattico ALL'ESPERIENZA 1 |
|
|
|
|
|
|
Il colore degli oggetti cambia nelle diverse
situazioni di luce proposte. Possiamo distinguere i diversi colori
degli oggetti solo se questi sono illuminati. Al buio, infatti nessun
oggetto appare colorato. Quindi non sono gli oggetti ad essere
colorati, ma è la luce che li fa apparire tali ai nostri occhi. Un corpo opaco, quando viene colpito da un raggio di luce bianca può assorbirlo completamente risultando così nero, può diffonderlo completamente risultando in tal caso bianco o, infine, può diffonderlo solo parzialmente ed appare ad es. rosso, perché rosso è il colore che viene diffuso. Dopo che il raggio luminoso viene diffuso da un
oggetto colpisce i nostri occhi. All'interno dell'occhio si trovano dei
recettori che sono sensibili ai diversi colori. Quando i recettori
sensibili al colore rosso vengono colpiti mandano stimoli nervosi al cervello, il quale li traduce nei colori: è quindi il nostro sistema
percettivo a creare i colori. Più in particolare, responsabile della
percezione del colore è la retina. Essa è costituita da due tipi di
cellule che, per la loro particolare forma, prendono il nome di coni
e bastoncelli. I bastoncelli permettono una
visione in bianco e nero; i coni consentono la percezione del colore; ce
ne sono di tre tipi: quelli sensibili al rosso (massimo di sensibilità
a 560 nm), al blu (430 nm) e al verde (530 nm).
I coni, colpiti dalla luce, subiscono una
trasformazione chimica in seguito alla quale inviano un impulso nervoso
al cervello che registra la presenza del colore. I coni sono attivi solo
in presenza di luce. Se questa è molto scarsa solo i bastoncelli
funzionano e, di conseguenza, gli oggetti ci appaiono grigi. Il colore, quindi, non è una proprietà
intrinseca di quell'oggetto ma è il risultato di processi che avvengono
nel nostro occhio e nel nostro cervello, è
una qualità della nostra sensazione, anche se esso dipende dalle
proprietà fisiche della sorgente che illumina e dei corpi che vengono
illuminati. "… il colore percepito assumiamo che sia
il risultato di una misura eseguita dall'occhio e di una interpretazione
data dal cervello della composizione spettrale della radiazione
osservata" (K. Nassau - Cfr. A. Frova (a
cura di), 1994, quaderno n°78, Le Scienze). |
|
E’ senz’altro vero che in una certa misura il colore di un oggetto si modifica quando viene illuminato dalla luce solare o da altre sorgenti di luce. Tuttavia questi sono effetti piccoli rispetto a quelli che potremmo attenderci per le variazioni delle proprietà fisiche delle sorgenti. Di fatto i colori degli oggetti tendono a mantenersi relativamente invariati anche per variazioni notevoli della radiazione illuminante. Questo fenomeno percettivo è chiamato costanza del colore. E’ come se il nostro sistema visivo fosse in grado di valutare le proprietà spettrali della radiazione illuminante così da poterne compensare gli effetti sull’apparenza degli oggetti illuminati. Secondo la teoria formulata da Land ( 1986) l’eccitazione prodotta da un oggetto colorato verrebbe considerata in rapporto a tutto quello che gli sta intorno o meglio in rapporto con l’eccitazione media che l’ambiente produce nei tre tipi di coni. Questo confronto permetterebbe di scartare gli effetti che la sorgente illuminante ha tanto su quell’oggetto come su tutto l’ambiente. La costanza del colore non può essere spiegata in modo soddisfacente solo in base a meccanismi retinici e implica certamente fenomeni che avvengono a livello cerebrale. |
 CHE COSA FAR NOTARE
CHE COSA FAR NOTARE CHE COSA SUCCEDE
CHE COSA SUCCEDE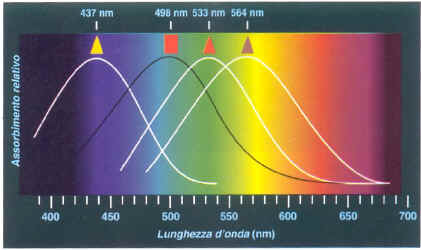
 PER APPROFONDIRE
PER APPROFONDIRE